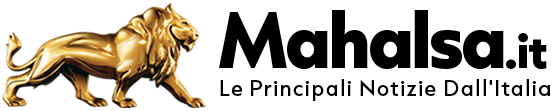I segni dell’incendio non ci sono più. Il capannone di via Toscana nel Macrolotto di Prato, ex sede dell’azienda Teresa Moda in cui 11 anni fa bruciarono vivi sette operai cinesi che lì vivevano (in loculi ricavati con il cartongesso) e cucivano abiti e magliette in condizioni disumane, per 14-16 ore al giorno, è stato ristrutturato e ri-affittato, anche se non ci sono insegne. I proprietari immobiliari italiani, condannati in primo e secondo grado (sei anni e mezzo di reclusione, poi ridotti a quattro), nel 2019 sono stati assolti in Cassazione dall’accusa di omicidio colposo plurimo, sentenza che ha seppellito per sempre l’ipotesi investigativa di contrastare gli illeciti delle ditte cinesi partendo da chi affitta loro gli spazi produttivi senza preoccuparsi di cosa avviene lì dentro.
Il più grande «mercato» all’ingrosso d’Europa
«Teresa Moda? Noi non sappiamo nulla», rispondono a monosillabi gli operai cinesi e pakistani che lavorano nelle vicine ditte di abbigliamento (i cosiddetti “pronto moda”), sbucando dietro “muri” di abiti estivi dai colori sgargianti pronti per la vendita, protetti da telecamere ad ogni angolo. A pochi passi ci sono montagne di sacchi neri che contengono gli scarti delle lavorazioni, ritagli di tessuto da smaltire chissà dove. Tutto intorno è un via-vai incessante di auto, camion, motorini e soprattutto furgoni polacchi, francesi e italiani, venuti a rifornirsi di abiti low cost nel più grande “mercato” all’ingrosso d’Europa: più di 4.300 aziende cinesi che nel giro di 48 ore sono in grado di confezionare migliaia e migliaia di capi grazie a un esercito di “schiavi” orientali e, da qualche anno, anche pakistani, bengalesi, indiani. Il distretto cinese degli abiti low cost sembra brillare come e più di prima.
Al momento del rogo di Teresa Moda, era la fine del 2013, Prato e la Toscana ebbero un sussulto: non è tollerabile – si disse allora –. che in una regione adorata dai turisti e apprezzata per il buon vivere, resistano situazioni di sfruttamento lavorativo e di evasione fiscale così spinte. Oggi la situazione è peggiore di allora. Perché dall’illegalità e dall’evasione si è passati alla criminalità.
«Mafia cinese», l’ha definita il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, che negli ultimi mesi si è trovato a contrastare una guerra tra bande cinesi l’una contro l’altra armata che puntano a controllare il mercato delle grucce, gli appendiabiti in metallo da pochi centesimi l’uno fondamentali per chi produce abiti e magliette. Coltelli, spranghe, pallottole: quindici episodi violenti dal giugno scorso a oggi e collegamenti inquietanti con l’omicidio di due cinesi a Roma nei giorni scorsi e con l’incendio di un magazzino di vestiti cinesi vicino Madrid, in Spagna, a fine febbraio. Il responso fa paura: organizzazioni internazionali che hanno rapporti con altre realtà criminali come ’ndrangheta, camorra, Sacra Corona unita. «Finora non si sono percepiti i rischi della criminalità cinese – dice Tescaroli al Sole 24 Ore – adesso serve una presa di coscienza da parte di istituzioni e cittadini perché gli atti di violenza che stanno aumentando costituiscono un pericolo e annichiliscono la concorrenza economica».
La lotta alla «mafia cinese»
Come la mafia nostrana è stata sconfitta grazie (soprattutto) ai pentiti, così la criminalità cinese può essere aggredita estendendo ai collaboratori e testimoni di giustizia le stesse misure di assistenza e di protezione straordinaria, sostiene il procuratore: «Dal 6 febbraio, quando ho fatto un appello invitando le persone sfruttate a rivolgersi all’autorità giudiziaria, si sono presentati in Procura in 52 tra cinesi e pakistani», annuncia Tescaroli aggiungendo che «non era mai accaduto in passato». Può essere il segnale di una svolta, che però ora ha bisogno «di volontà politica e di interventi legislativi». Anche per salvaguardare l’economia sana della città: «L’evasione cinese condiziona la libera concorrenza, nessuno può competere con chi sfrutta lavoratori in modo disumano».