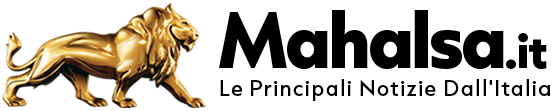Nel panorama globale scosso dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente e dai venti di un neoprotezionismo che già prima dell’applicazione concreta dei dazi sta spaccando le rotte consolidate della globalizzazione, le prospettive economiche dell’Eurozona tracciate lunedì dalle previsioni di primavera della Commissione Ue non sono esaltanti. E lo sono ancora meno quelle attribuite all’Italia, che con il suo +0,7% di crescita per quest’anno e il +0,9% previsto per il 2026 (le stime ufficiali del Governo parlano invece di +0,6% e +0,8%) viaggerebbe rispettivamente due e cinque decimali sotto il ritmo medio tenuto dai Paesi della moneta unica.
Ma accanto alle previsioni macro, difficili da incidere nel marmo quando devono avventurarsi in scenari mitragliati dalle raffiche di annunci politici non sempre razionali, sono i dati granulari elaborati dai tecnici di Bruxelles a offrire gli spunti più interessanti. Che, per chi non abbia troppa voglia di avventurarsi nella giungla fitta di dati e tabelle, possono essere sintetizzati così: la ripresa italiana post pandemica ha raggiunto risultati importanti, soprattutto quando si guarda al Pil pro capite a parità di potere d’acquisto che misura le performance dell’economia al netto dei colpi assestati da demografia e inflazione in modo differente da Stato a Stato. Su questo terreno, per esempio, l’Italia è arrivata ora a pareggiare i conti con la Francia, cancellando una distanza nel prodotto per abitante che era del 10,1% nel 2020 e dell’8,8% nel 2015, ha quasi dimezzato lo “spread” con la Germania, passato in cinque anni dal 24,3% al 13,9%, e ha ricucito i rapporti con la media dell’area Euro, da cui la separa un 5,9% invece del 10,7% del 2020 e del 9,4% registrato nel 2015 (il tutto ovviamente misurato sui confini attuali della moneta unica). Dati non banali, anche se frutto del confronto con un’area che, a partire proprio dalla Germania, non spicca certo per la vivacità della crescita.
Una spinta forte è arrivata dall’aumento dell’occupazione, che ha macinato record negli ultimi due anni ma, suggeriscono i dati, zoppica nel peso specifico riassunto dalla quantità di prodotto per occupato. E, ultimo ma cruciale capitolo del riassunto, la strada che andrebbe percorsa per recuperare i danni generati dalla lunga stagnazione pre-pandemica è ancora molto lunga; perché il peso economico (e quindi il benessere relativo) raggiunto dall’Italia 25, 20 o solo 15 anni fa resta lontanissimo.
I numeri, allora. Quelli più incoraggianti, si diceva, nascono dai calcoli sul Pil per abitante. Che hanno un pregio, perché sterilizzano gli impatti di una dinamica demografica da noi ancor più gelida rispetto al resto dell’area. Ma hanno anche un difetto: dal momento che il debito pubblico, su cui l’Italia è largamente primatista fra i grandi Paesi del continente e già vede la testa anche nella classifica generale con il prossimo superamento della Grecia, si sostiene con le entrate generate dal prodotto complessivo, a prescindere da quanti siano i suoi autori.
Nel conteggio basato sugli standard a parità di potere d’acquisto, il Pil italiano non si è limitato a recuperare il proprio posizionamento europeo pre-Covid, ma ha superato di un soffio le condizioni del 2015, quando era in linea alla media dell’Eurozona oggi superata dell’1,1%%. Oltre a riagguantare i livelli francesi e a quasi dimezzare il gap con la Germania, questo indicatore gioca una gara complicata con la Spagna, che in questi anni è fra le regine della crescita europea: nel 2025 ciascun italiano è “titolare” di un prodotto interno del 6,2% superiore a quello di ogni spagnolo, dieci anni fa la distanza era marginalmente più ridotta (+5,9%) ma nel 2020, anno di crollo dell’economia di entrambi i Paesi, era del 13,1%.