Non chiamateli nuovi Ogm. È lo slogan ricorrente sulle nuove biotecnologie agricole per le quali il Consiglio Ue ha dato il via libera alla trattativa sul regolamento che ne autorizza coltivazione in campo e commercializzazione. Le nuove tecniche genomiche (Ngt o Tea secondo l’acronimo italiano), valse un Nobel per la chimica assegnato nel 2020 a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, si differenziano sostanzialmente dagli Ogm per la mancanza di inserimento di Dna estraneo alla pianta. Utilizzando solo geni appartenenti alla stessa specie accelerano in laboratorio un procedimento che avviene in natura in tempi molto più lunghi. L’obiettivo è selezionare varietà più produttive, resistenti agli stress climatici e con un minor fabbisogno idrico.
Il mancato sviluppo delle biotecnologie in Europa, eccezione quasi unica nel panorama mondiale, deriva dall’equiparazione sotto il profilo giuridico delle Tea ai vecchi Ogm a opera di una sentenza della Corte di giustizia Ue del 2018, secondo cui in assenza di una normativa specifica sono soggette al regolamento sugli Ogm del 2001, quindi, di fatto vietate. Nel frattempo la ricerca è andata avanti ma è rimasta confinata nei laboratori. L’Italia ha provato a fare da apripista con una legge dello scorso anno che autorizza, a determinate condizioni, la sperimentazione in campo, ma i pochi metri quadrati dedicati allo sviluppo di una varietà di riso in Lomellina sono stati distrutti poco dopo l’avvio, così come le viti (tra i comparti più promettenti con cereali, pomodori e agrumi) in Valpolicella. Eppure sulla carta tutte le organizzazioni agricole, a eccezione di quelle del biologico, sono favorevoli.
La proposta sul tavolo Ue risale al luglio 2023, e distingue le nuove tecniche in due categorie: in estrema sintesi le Tea (fino a un certo numero di modifiche), con obbligo di etichettatura solo per le sementi, e una seconda categoria, in cui rientrano gli Ogm e le nuove tecniche oltre le 20 modifiche genetiche, che sarebbero soggette a una specifica procedura di autorizzazione e valutazione del rischio prima dell’immissione sul mercato.
Gli Stati membri manterrebbero il diritto di opt-out previsto per gli Ogm. I nodi principali riguardano la trasparenza dei brevetti, sui quali la Commissione dovrà presentare un rapporto, a un anno dal nuovo regolamento, sull’impatto delle procedure sull’innovazione, la competitività del settore sementiero e la disponibilità di sementi per gli agricoltori. Un altro paletto riguarda la non ammissibilità di modifiche sulla tolleranza agli erbicidi. Il negoziato vero parte adesso, difficilmente la presidenza polacca riuscirà a chiudere un accordo entro il semestre, che è possibile entro la fine dell’anno sotto presidenza danese
Per il direttore di Assosementi, Alberto Lipparini, la riforma «offre un’opportunità di sviluppo per tutte le piccole e medie imprese del mondo sementiero europeo. Sui brevetti la nostra posizione è semplice: l’innovazione costa, quindi come in tutti gli altri settori è necessario garantire una remunerazione degli investimenti, fermo restando la necessità di garantire il libero accesso. Bisogna trovare un equilibrio tra queste due istanze contrapposte, questo è possibile prevedendo licenze obbligatorie sui nuovi ritrovati, frutto di un compromesso economico». L’obbligo di etichettatura delle sementi, aggiunge, «di per sé non è un problema, ma l’indicazione sul prodotto finito rischia di essere più complessa a discapito degli obiettivi di trasparenza».




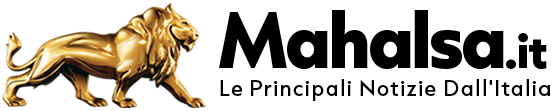

-U72816888606OFx-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?r=1170x507)







