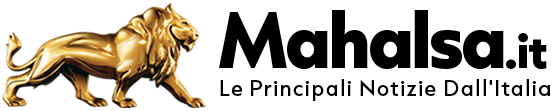Negli anni ’80, in provincia di Napoli, le campagne di Giugliano ospitavano la maggior produzione italiana di ortofrutta e le fragole di Acerra erano famose in tutto il mondo. Poi, nel 1996, la commissione parlamentare di inchiesta accerta per la prima volta l’esistenza di discariche illegali in quella che verrà poi chiamata la Terra dei fuochi. E nelle campagne che vanno dal mare di Napoli alle prime alture del Casertano nulla è stato più come prima. Ci sono stati anni in cui nessuno voleva più comprare i prodotti agricoli di una terra inquinata dai rifiuti tossici. «Da primi d’Italia siamo diventati gli ultimi» racconta Francesco Pirozzi, che proprio a Giugliano ha un’azienda agricola e presiede la sede locale della Coldiretti cittadina. «Vendevamo sottocosto. Le pesche di Caserta sono rinomate, in quegli anni si vendevano a 35-40 centesimi al chilo, poi all’improvviso scesero sotto i 20 centesimi. Noi agricoltori facemmo anche uno sciopero a Pozzuoli, per dire basta».
Il momento più buio? Domenico Sabatino ci pensa un po’. Anche lui produce frutta a Calvizzano, in piena Terra dei fuochi, e oggi è vicepresidente provinciale della Coldiretti di Napoli. «Il momento peggiore è stato tra il 2006 e il 2009 – dice – quando sui banchi dei supermercati di tutta Italia, per tranquillizzare i consumatori, si appendevano i cartelli con scritto “non vendiamo prodotti campani”».
Da qualche anno le cose per gli agricoltori della Terra dei fuochi vanno meglio. «Certo, rispetto a trent’anni fa la produzione è diminuita – ammette Sabatino – ma i prezzi dei nostri prodotti sono tornati in linea con la media di mercato». Il marchio d’infamia sembrava dunque un ricordo sbiadito. Fino a qualche giorno fa, quando la paura è tornata insieme alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che dopo anni di silenzio ha riacceso i riflettori sulle vicende di questo lembo di terra.
Dopo un processo durato sei anni, il 30 gennaio il tribunale di Strasburgo ha condannato l’Italia per non aver tutelato a sufficienza dall’inquinamento ambientale la salute dei 3 milioni di abitanti dei 90 comuni della Terra dei fuochi. «Come agricoltori siamo preoccupati – dice Sabatino – basta un post sbagliato sui social, e il boicottaggio contro i prodotti agricoli campani potrebbe ripartire».
Non riaprite quel tombino, insomma. Ma la frutta e la verdura della Terra dei fuochi è sicura, o no? Secondo i suoi agricoltori, nella stragrande maggioranza dei casi lo è sempre stata. La relazione della commissione interministeriale che, su richiesta del decreto Terra dei fuochi del 2013, fece i monitoraggi sui terreni agricoli, stabilì che solo il 3% delle aree analizzate era inquinata. La mappa risale però al 2016, quasi dieci anni fa. «Nel 2016 fu eseguita una prima campagna massiva su tutto il territorio regionale», spiega il professor Antonio Limone, direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, a quell’epoca membro della commissione interministeriale che elaborò la mappa. «Successivamente – assicura il professore – sono state effettuate campagne di monitoraggio dinamico, tutt’ora in corso, con particolare riferimento alle acque sotterranee». Il Covid ha rallentato le indagini, ammette, ma il lavoro continua anche oggi. «Noi agricoltori eravamo i primi a volere i controlli – dice Sabatino – in certi momenti ce li siamo fatti anche da soli. Quando si sono accesi i riflettori sulla Terra dei fuochi esportavamo già in Russia, in Giappone, negli Emirati Arabi, e tutti questi Paesi volevano prima vedere la certificazione Global Gap, lo standard per la sostenibilità ambientale riconosciuto dalla maggior parte delle catene della grande distribuzione». Quanto ai roghi e agli sversamenti di rifiuti tossici nei terreni, Sabatino dice che non ce ne sono più da anni: «C’è l’esercito qui», assicura.