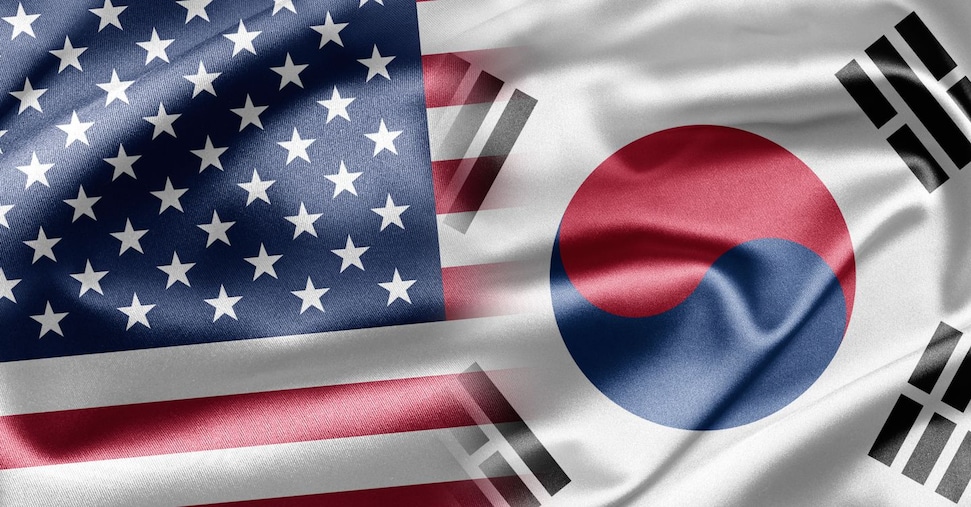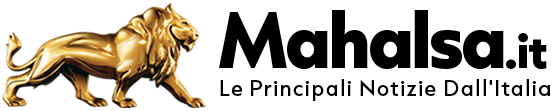La chiamano la Davos dell’Artico. Un summit in grande spolvero a Reykjavik, in Islanda con ministri, capi di Stato e rappresentati di sessanta Paesi e duemila partecipanti. L’Arctic Circle Assembly 2025 ha aperto le porte il 16 ottobre con una tre giorni dedicata a geopolitica ed economia. E lo fa, coincidenze astrali, nei giorni in cui la portacontainer cinese Istanbul Bridge ha raggiunto il Regno Unito via Northern Sea Route in circa 20 giorni, la metà rispetto ai 40–50 via Suez. La data è da cerchio rosso sul calendario quando il 15 ottobre il carico, componentistica e beni industriali, ha toccato Felixstowe, inaugurando un collegamento commerciale Asia-Europa via Artico.
Il contesto internazionale
Ma è sul palco dell’assemblea che si fanno i giochi. Dalla Groenlandia, la linea è netta sulla governance dei territori e delle risorse. “Ci assumiamo la responsabilità del luogo che chiamiamo casa, siamo padroni del nostro Paese e vogliamo che ciò sia rispettato dagli altri”, dice Vivian Motzfeldt, ministra degli Esteri della Groenlandia. È il punto di partenza per ogni piano su porti, miniere, cavi, corridoi logistici: l’ambiente e la sostenibilità. Dal Baltico arriva il registro securitario, che impatta direttamente premi assicurativi e investimenti. “Noi finlandesi non rappresentiamo una minaccia per nessuno, vogliamo semplicemente proteggere ciò che ci è caro”, afferma Elina Valtonen, ministra degli Esteri della Finlandia. In controluce, rotte protette, standard più severi, costi di compliance che entrano nei business plan. Il taglio internazionale lo dà l’intervento giapponese, centrato sulla rilevanza sistemica dell’Artico. “Siete qui perché conoscete l’Artico e riconoscete le molte questioni che devono essere discusse su questa regione, questioni che, in un contesto più ampio, riguardano l’intero mondo”, sottolinea la Principessa Takamado. Tradotto in agenda: ricerca come infrastruttura, dati come riduzione del rischio, geopolitica e ancora geopolitica.
Il business del ghiaccio
“Dobbiamo essere più operativi, ecco perché il nostro governo cerca attivamente opportunità di investimento in sicurezza, come possiamo posizionarci strategicamente e rafforzare l’hub che è l’Islanda”, afferma Kristrún Frostadóttir, prima ministra dell’Islanda. Nel mezzo scorrono i temi tecnici, con il green shipping che incrocia la domanda di carburanti alternativi, l’adeguamento delle flotte ice-class, l’efficienza energetica. I porti fanno i conti con canali di accesso, dragaggi, rumore subacqueo, standard ambientali. La blue economy lavora su acquacoltura, logistica del freddo, tracciabilità, valore aggiunto locale. Il ritorno di fiamma delle rotte settentrionali riapre la discussione sui corridoi di dati e energia, cavi e hub digitali, progetti che richiedono autorizzazioni, garanzie pubbliche, partenariati con la finanza. Qui la stabilità istituzionale pesa quanto i chilometri risparmiati. Ma è all’economia che tutti guardano.
L’Italia verso il Forum di Roma
All’Assembly partecipa Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa con delega su quei territori, con un presidio orientato a sicurezza, ricerca, industria navale, nel percorso che approderà all’”Arctic Circle Forum – Polar Dialogue”, che per la prima volta si svolgerà in Italia, a Roma il 3 e 4 marzo prossimi. Per l’Italia ci sono anche il Cnr, l’Ingv e l’Isp, l’istituto di scienze polari.
La cornice è quella, tutta domestica, tracciata nei giorni scorsi dal ministro della Difesa Guido Crosetto davanti all’assemblea di Confitarma: mare e fondali come frontiera della competizione economica e tecnologica, protezione di infrastrutture e catene strategiche come leva di crescita. Il filo che unisce i panel della giornata è chiaro, rotte più rapide non significano automaticamente costi più bassi. Servono investimenti in scali del Nord, servizi di soccorso, sistemi di monitoraggio, flotte adeguate, formazione tecnica, cornici assicurative aggiornate. La chiusura del primo giorno detta l’agenda: i governi si interrogano sui nuovi assetti nello scacchiere internazionale, l’industria chiede certezza di regole e di tempi, la finanza guarda al rapporto tra rischio e rendimento. Reykjavík fa da camera di compensazione, tra geopolitica e contabilità, tra rotte fredde e mercati caldi.