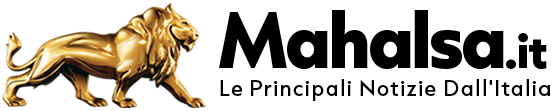Il trasporto su strada rappresenta la principale fonte di emissioni di C02 nell’ambito dei processi di distribuzione logistica, «contribuendo a ben il 92,5% del totale». Ma, «migliorando la saturazione dei veicoli, si è dimostrato possibile ottenere una riduzione delle emissioni fino al 50%». Parallelamente, «aumentando l’utilizzo del trasporto intermodale, si è osservata una potenziale riduzione delle emissioni fino al 22%». È quanto emerso da uno studio del Politecnico di Milano portato avanti in collaborazione con Syngenta, uno dei colossi dell’agribusiness (350 dipendenti in Italia e 5mila collaboratori nel mondo).
Il progetto ha affrontato uno degli aspetti più critici della sostenibilità nel settore logistico, cioè l’impatto ambientale delle operazioni di trasporto merci, con il fine sviluppare un metodo sistematico e applicabile per quantificare le emissioni di CO2e (anidride carbonica equivalente) nelle attività di distribuzione, «colmando così una lacuna nella letteratura esistente e offrendo – spiega Sara Perotti, professore associato di logistica al dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico – un approccio strutturato e implementabile in contesti aziendali reali. Lo studio propone un modello per la valutazione dell’impatto ambientale conforme al framework Glec (Global logistics emissions council), che è uno degli elementi utilizzati oggi dalle aziende per sviluppare una metodologia condivisa che consenta di avere benchmark per misurare le proprie performance di sostenibilità».
Nuovo modello sviluppato su un caso aziendale
Inizialmente, prosegue Perotti, «è stato sviluppato un modello basato su una revisione approfondita della letteratura e delle linee guida esistenti nel settore. Successivamente, il modello è stato applicato, e perfezionato, attraverso un caso aziendale reale, utilizzando, come esempio, Syngenta Italia, un’azienda del settore agroalimentare. Dallo studio è emerso, tra l’altro, che uno dei temi su cui è possibile lavorare riguarda la saturazione dei mezzi, ovvero la possibilità di sfruttare al meglio l’utilizzazione dei mezzi stessi: saturare meglio significa anche avere meno mezzi in circolazione, cosa che si può ottenere andando, magari, a ragionare meglio su tempistiche e accorpamenti di eventuali ordini e concentrandosi pure sulla questione dei ritorni a vuoto, che impatta notevolmente, proprio in termini di percentuale di saturazione dei mezzi».
Perotti aggiunge che si è lavorato anche «sul fattore di carico, cioè su quanto è mediamente pieno il mezzo quando viaggia. E qui c’è il tema dell’opportunità di avere una buona capacità nell’organizzazione e nella gestione dei viaggi; che, in questo caso, è di competenza dei fornitori di servizi logistici, a cui Syngenta si appoggia. Operando sui vari fattori cui ho fatto cenno, si potrebbe arrivare fino ad un ritorno del 50% in termini di performance».
La sfida della supply chain
Stefano Maksimovic, direttore supply chain per l’Italia di Syngenta, da parte sua, sottolinea che, rispetto al 2022, l’azienda si è impegnata «a ridurre le emissioni scope 1 e 2, sostanzialmente all’interno delle nostre fabbriche (che producono sementi, come cereali, mais e soia, prodotti per la protezione delle colture e soluzioni digitali, ndr) del 38%. Lo scope 3 (relativo alla supply chain, ndr), invece, è un’area sulla quale ci stiamo impegnando. E questo lavoro, svolto con il Politecnico, si colloca proprio all’interno di questa sfida. Il nostro obiettivo è stato quello di iniziare a misurare qual è l’impatto, per quanto concerne la distribuzione logistica sul mercato Italia e, sulla base di quell’impatto, definire dei target di miglioramento della nostra sostenibilità, dal 2026 avanti. Mentre il 2025, di fatto, verrà utilizzato proprio per definire questi target».