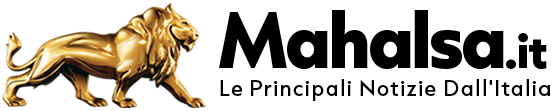Che ruolo ha il Medio Oriente nell’agenda di Donald Trump, fresco di elezione a 47esimo presidente degli Stati Uniti? Dalla guerra a Gaza ai difficili rapporti con l’Iran, ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali del 5 novembre 2024 negli Stati Uniti. Sulla rielezione, a sorpresa ma non troppo, del candidato repubblicano hanno pesato molto le preoccupazioni per le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Secondo i sondaggi, proprio il tema del conflitto in Medio Oriente è stato tra le priorità per gli elettori che si sono recati alle urne lo scorso martedì. In particolare, il conflitto a Gaza e in Libano ha influenzato il voto dell’elettorato arabo-americano favorendo la rielezione di Trump.
Né i Democratici né i Repubblicani hanno saputo affrontare il tema del conflitto israelo-palestinese in maniera convincente con Trump che ha manifestato un sostegno incondizionato per Israele pur promettendo la fine della guerra e Kamala Harris, in continuità con l’amministrazione di Joe Biden, che si è dimostrata incapace di negoziare un cessate il fuoco a Gaza senza fermare la fornitura di armi Usa a Israele. A questo punto, una volta insediatosi, il tycoon che ha promesso la “fine delle guerre” dovrà affrontare i nodi principali della politica estera Usa a partire dallo scontro con l’Iran e dal conflitto in Medio Oriente.
Cosa farà Trump con Israele e Palestina
Quando Trump è stato per la prima volta alla Casa Bianca (2017-2021) si è dimostrato il più grande alleato di Israele di sempre. Il premier Benjamin Netanyahu lo ha definito il “miglior amico che Israele abbia mai avuto”. L’allora presidente Usa ha riconosciuto le rivendicazioni territoriali di Tel Aviv sulle Alture del Golan, annesse unilaterlamente nel 1967. Non solo, ha spostato l’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme e ha favorito più di ogni altro gli accordi di Abramo tra Israele e Emirati Arabi Uniti (2020) puntando sull’asse di ferro tra Washington e Arabia Saudita.
La vittoria di Trump è la vittoria dell’America che odia le donne
In campagna elettorale, Trump ha assicurato che Netanyahu sarebbe stato libero “di finire il suo lavoro” a Gaza, mostrandosi quindi contrario ai tentativi di limitare i fronti di guerra aperti dall’esercito israeliano (Idf) dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. In altre parole, per Trump la fine della guerra in Medio Oriente equivale alla “vittoria” di Israele e ad un accordo tra israeliani e sauditi che archivi le rivendicazioni di uno stato palestinese.
I politici democratici hanno pagato molto l’incapacità dimostrata di poter chiudere la guerra con un cessate il fuoco a Gaza e in Libano. E così anche il presidente uscente Joe Biden si è in realtà dimostrato incapace di imporre un freno ai raid israeliani, sebbene abbia mostrato una maggiore efficacia nel contenere gli attacchi israeliani contro l’Iran dello scorso 26 ottobre, evitando di coinvolgere le centrali nucleari del paese, e impedendo per il momento un’ulteriore escalation del conflitto.
E così, durante la campagna elettorale di Harris e fino alla vigilia del voto, negli Usa e a New York, non sono mancate le manifestazioni di dissenso degli attivisti pro-Palestina per la mancata condanna inequivocabile del genocidio in corso a Gaza da parte di Washington. Eppure la candidata democratica aveva enfatizzato nei suoi discorsi la crisi umanitaria nella Striscia e aveva più volte fatto riferimento alla necessità di un cessate il fuoco. Non solo, durante la visita di Netanyahu alla Casa Bianca dello scorso luglio, Harris aveva assicurato che gli Usa non sarebbero rimasti “in silenzio” sulla situazione a Gaza, esprimendo preoccupazione per la morte dei civili.
Nonostante ciò, a confermare che la questione della guerra in Medio Oriente ha contato molto sulla sconfitta di Harris era arrivato alla vigilia del voto lo stop da parte del miliardario editore del Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, al sostegno da parte della testata per la candidata democratica proprio per il suo appoggio nell’ultimo anno al “genocidio di Israele in Palestina”. D’altra parte, la stessa candidata democratica, Hillary Clinton, nel 2016 era stata duramente criticata per il suo sostegno alla Fratellanza musulmana in Egitto e Libia. In quell’occasione vennero resi noti i suoi scambi di email con l’ambasciatrice Usa, Anne Patterson, per discreditarne le credenziali in politica estera.
Cosa farà Trump con l’Iran
Gli effetti più significativi della rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti potrebbero venire proprio dai rapporti bilaterali tra Washington e Teheran. Al tempo della presidenza di Barack Obama l’accordo sul nucleare, siglato nel luglio 2015 a Vienna, aveva segnato un riavvicinamento senza precedenti tra i due paesi che dalla crisi degli ostaggi dopo la rivoluzione islamica del 1979 facevano fatica a parlarsi. Ma Trump, a partire dal 2018, aveva rimesso tutto di nuovo in discussione, strappando quell’accordo, imponendo nuove sanzioni contro l’Iran, ordinando l’uccisione della figura chiave in quella fase nella gestione dei conflitti regionali, la guida delle milizie al-Quds, Qassem Soleimani, e ponendo il veto su qualsiasi iniziativa bilaterale da parte di paesi terzi che volessero bypassare le nuove sanzioni Usa contro l’Iran. Queste iniziative hanno messo in seria difficoltà l’economia iraniana e hanno rafforzato la componente conservatrice portando all’elezione dell’ex presidente, Ebrahim Raisi nel 2021.
Dal canto suo, Biden, soprattutto nella prima fase della sua presidenza, ha provato a riportare Teheran al tavolo negoziale sul nucleare. Non ci è riuscito in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina a causa del sostegno dimostrato dall’Iran alla Russia di Vladimir Putin con la fornitura di droni Shahed usati da Mosca per colpire Kiev. Negli ultimi anni, l’asse tra Mosca e Teheran è andato rafforzandosi con accordi militari reciproci che hanno sicuramente ostacolato la fine delle sanzioni internazionali contro l’Iran mentre le proteste anti-governative hanno riempito le strade iraniane in nome del movimento “Donna, vita, libertà”.
Alla vigilia del voto Usa, la guida suprema iraniana, Ali Khamenei aveva promesso una risposta “devastante” contro i raid israeliani dello scorso 26 ottobre, in seguito agli attacchi iraniani contro Tel Aviv dello scorso primo ottobre, motivati dall’uccisione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, a Beirut il 27 settembre. I pasdaran iraniani avevano promesso un raid “doloroso e definitivo” prima del voto negli Usa. Tuttavia, queste dichiarazioni più che in relazione alle elezioni negli Stati Uniti vanno interpretate in riferimento alle difficoltà per il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza, più volte promesso da Washington, e ancora lontano, secondo quanto emerge fin qui dalle dichiarazioni di Hamas.
Trump e le milizie sciite
La politica estera di disimpegno dal Medio Oriente, promossa da Trump nella sua prima presidenza, potrebbe essere la chiave di lettura anche del suo secondo mandato. Questa strategia ha di fatto favorito il rafforzamento dell’influenza regionale iraniana, in particolare in Siria e in Iraq ma anche in Yemen e in Afghanistan. E ha alimentato la logica della guerra per procura con l’attivazione e il consolidamento del ruolo delle milizie sciite nella regione.
Tuttavia, negli ultimi anni, è mancata una politica estera Usa di lungo corso in questi paesi tanto che lo stesso Trump ha dovuto più volte smentire sé stesso in merito al ritiro da aree strategiche per evitare l’avanzata di altre forze impegnate a vario titolo nella regione. Primo fra tutti l’esercito turco che ha approfittato largamente dell’incertezza nella politica estera Usa in Medio Oriente per colpire ripetutamente le forze curde nel Nord della Siria, nonostante sia i curdi peshmerga in Iraq sia i curdi delle Unità di protezione maschile e femminile (Ypg-Ypj) in Siria siano stati i principali artefici della sconfitta sul campo dei jihadisti dello Stato islamico (Isis).
Questa inconsistenza nella politica estera di Washington in Medioriente durante il primo mandato di Trump, ha quindi, da una parte, messo in crisi il tradizionale asse tra Turchia e Stati Uniti all’interno della Nato, dall’altra, ha favorito la spaccatura della Libia con il caotico conflitto che è ancora in corso. Queste dinamiche potrebbero tornare a farsi vive nei prossimi anni a causa di una possibile sempre più limitata presenza militare statunitense nella regione.
Trump e i dittatori
E così il ritorno di Trump significherà un appoggio incondizionato per i regimi autoritari in Nord Africa e in Medio Oriente. Gli Usa si mostreranno sempre più riluttanti ad essere coinvolti nei conflitti regionali e pronti ad accordi ad hoc per la soluzione delle crisi locali. A partire dal sostegno inequivocabile per la monarchia saudita. Nei prossimi anni gli Usa eviteranno di fare troppe domande sul mancato rispetto dei diritti umani in molti dei paesi della regione, come è già avvenuto in occasione dell’assassinio del giornalista saudita, Jamal Khashoggi (2018). In quella fase, Trump e l’allora Segretario di Stato, Mike Pompeo, avevano permesso che la catena di responsabilità che coinvolgeva le più alte cariche della monarchia saudita non venisse alla luce.
Non solo, per Trump il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi rappresenta il suo “dittatore preferito”. Quindi ancora una volta questo significherà favorire le politiche repressive promosse da militari e autocrati in Nord Africa in nome degli interessi geopolitici statunitensi. Come, d’altra parte, stava facendo lo stesso Biden che ha ripristinato gli aiuti militari Usa al Cairo pari a 1,3 miliardi di dollari annui, in nome del ruolo negoziale egiziano nel conflitto in corso a Gaza.
La rielezione di Donald Trump segnerà il futuro del Medio Oriente. Gli Stati Uniti sono parte del problema che impedisce una soluzione del conflitto israelo-palestinese. Biden non ha saputo imporre un cessate il fuoco che mettesse fine alla guerra e alla crisi umanitaria che va avanti da oltre un anno. Trump punterà tutto sull’alleanza con i sauditi per chiudere la pagina della guerra. Eppure in questo contesto la causa palestinese ha assunto una centralità più rilevante, in seguito al genocidio in corso a Gaza, rispetto agli anni scorsi. E quindi sarà difficile arrivare a una vera soluzione del conflitto che non includa il difficile e osteggiato riconoscimento di uno stato palestinese. Non solo, il protrarsi della guerra e le posizioni intransigenti dei repubblicani potrebbero esasperare il conflitto tra Israele e Iran aggravando l’estensione, già in corso, delle tensioni in Medio Oriente.