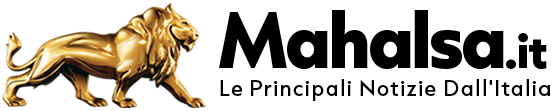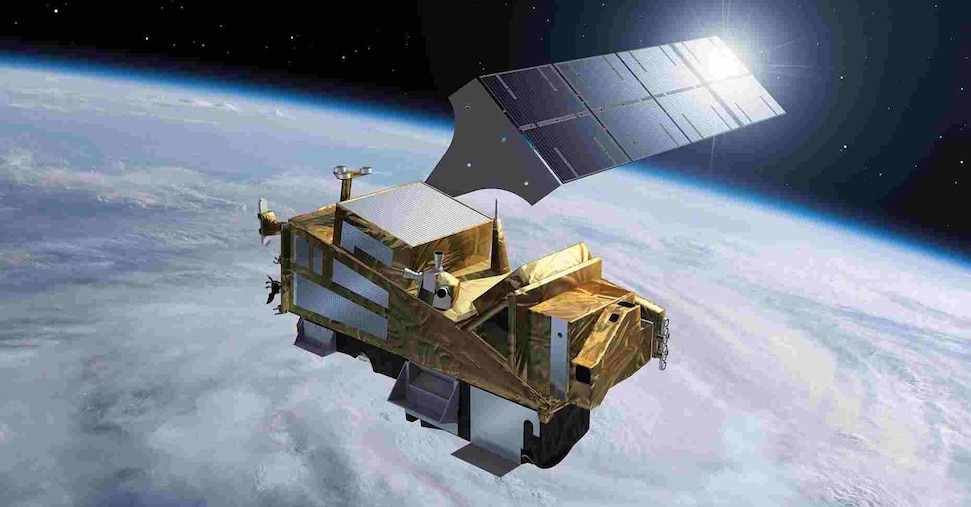Per gran parte della storia umana, una prole numerosa era uno status symbol importante. Sovrani dispotici come Gengis Khan lo hanno dimostrato: uno studio genetico del 2003 ha scoperto che un uomo su 200, a livello globale, potrebbe essere portatore del suo cromosoma Y. Più in generale, tutte le famiglie con maggiori risorse avevano più figli. Poi, nel XVIII secolo, la situazione iniziò a cambiare. Nei Paesi all’avanguardia della rivoluzione industriale il tasso di natalità cominciò a diminuire e furono proprio le classi più agiate a guidare la contrazione delle nascite. Nel XX secolo, la relazione inversa tra ricchezza e fecondità è diventata un dato di fatto e ormai da decenni si insegna nelle università come una legge cardine della demografia: man mano che i Paesi diventano più ricchi, cala il numero di figli per donna. Questa ipotesi ha plasmato innumerevoli previsioni sul futuro della popolazione globale, a partire dal World Population Prospects dell’Onu, che stima un picco della popolazione globale a 10,3 miliardi nel 2084. Una serie di ricercatori, però, ora sta mettendo in dubbio questi numeri e in particolare la nozione cardine alla loro base: che la crescente prosperità sopprima sempre la fecondità.
Paesi a medio reddito con bassi tassi di fecondità
Jesús Fernández-Villaverde, professore di economia all’università della Pennsylvania e prolifico ricercatore all’incrocio fra economia e demografia, ha recentemente osservato forti discrepanze tra i dati dell’Onu e la realtà sul campo, dimostrando che i Paesi a medio reddito stanno ora registrando tassi di fecondità più bassi rispetto a quelli di molte economie avanzate. Nel suo ultimo studio, Fernández-Villaverde sottolinea che Thailandia e Colombia nel 2024 hanno registrato entrambe tassi di fecondità intorno a 1,0 nati per donna, inferiori a quelli di economie avanzate note per la loro bassa fecondità come il Giappone (1,15) o l’Italia (1,11). E conclude: «La mia ipotesi è che entro il 2060 potremmo vedere le economie ricche come un gruppo con tassi di fecondità più elevati rispetto alle economie emergenti».
Scenderemo a 9 miliardi 30 anni prima del previsto
L’anno scorso in Colombia si sono registrate 510mila nascite, un calo del 22% in cinque anni e circa il 30% in meno rispetto alle previsioni delle Nazioni Unite. Dal Cile al Guatemala, la situazione è analoga. Nel 2024 il tasso di fecondità del Messico (1,55) è sceso per la prima volta al di sotto di quello degli Usa (1,6). Ma le discrepanze non si limitano all’America Latina. Nel 2024, anche le nascite in Azerbaigian (1,6), Turchia (1,48) e Iran (1,44) erano al di sotto delle previsioni e ben al di sotto del tasso di rimpiazzo, generalmente collocato a 2,1 figli per donna e ormai superato solo dai Paesi africani. La situazione in Cina è stranota: malgrado gli sforzi, non va oltre 1,1 figli per donna e anche l’India (1,9) è sotto il tasso di rimpiazzo. Secondo i calcoli di Fernández-Villaverde, l’impatto combinato del crollo demografico nei Paesi emergenti colloca la vera traiettoria globale lungo il percorso più basso indicato dalle Nazioni Unite, con un picco a circa 9 miliardi di individui nel 2054, 30 anni prima rispetto alle previsioni correnti.
Poli (Univ. Trento): maggiore fluidità nella gestione della vita
Una prospettiva non necessariamente negativa. «Il fatto che a un certo punto ci siano meno persone nel mondo non è detto che sia un disastro, anzi potrebbe essere positivo, considerato che siamo comunque troppi», commenta Roberto Poli, docente dell’Università di Trento e coordinatore di un master unico in Italia, dedicato allo studio del futuro. «Già adesso il pianeta fa fatica a reggere 8 miliardi di persone, con l’emergenza climatica, le crisi ambientali, alimentari e tutto il resto. Figurarsi se dovessimo arrivare a 10 miliardi, l’impatto sarebbe ancora più devastante», sottolinea. “Cominciare a parlare di un calo demografico ci offre la speranza di un futuro migliore, anche se è chiaro che la nuova situazione andrà gestita, perché ci troveremo in una società con pochi giovani e molti anziani», rileva. La soluzione sta, secondo Poli, in una maggiore fluidità nell’organizzazione della vita, in modo che studiare non sia relegato solo alla prima fase e lavorare si estenda in parte anche nel periodo della pensione.
Relazione invertita tra reddito e fecondità
L’Europa è un laboratorio interessante dell’inversione nel rapporto fra prosperità e fecondità: «Per molti anni, i Paesi europei più ricchi hanno avuto tassi di natalità più bassi rispetto a quelli più poveri. Questo andamento si è indebolito intorno al 2017, per poi invertirsi nel 2021», rileva Fernández-Villaverde. Questa inversione era già stata segnalata da un paper del 2022 firmato da quattro studiosi tedeschi (Matthias Doepke, Anne Hannusch, Fabian Kindermann e Michèle Tertilt), che dedica particolare attenzione al ruolo del lavoro femminile. Dal loro studio, intitolato “The Economics of Fertility: A New Era”, emerge chiaramente che i vecchi modelli non sono più universalmente validi: «Nei Paesi avanzati, la relazione fra reddito e fecondità si è appiattita e in alcuni casi si è invertita, mentre la relazione tra il lavoro delle donne e la fecondità è ora positiva». Lo studio rileva infatti che nei Paesi in cui più donne lavorano nascono più bambini (come in Danimarca, a 1,7 figli per donna) e sostengono che la compatibilità tra carriera e obiettivi familiari delle donne è ora un fattore chiave, individuando quattro elementi che facilitano la conciliazione tra carriera e maternità: politiche di apertura alla procreazione in qualsiasi configurazione familiare, norme sociali favorevoli, padri collaborativi e mercati del lavoro flessibili. E’ da qui che bisogna partire per impostare le politiche pubbliche sulla natalità.