Per oltre un decennio, l’Unione europea ha fronteggiato con difficoltà un contesto geopolitico sempre più complesso e turbolento. Tra conflitti ai confini, tensioni commerciali, competizione per l’accesso a materie prime rare e tecnologie strategiche, l’Ue ha subito una perdita di competitività e un progressivo declino economico. Per invertire questa tendenza, appare sempre più evidente la necessità di forti investimenti per una strategia di competitività a tutto campo che riduca la dipendenza dagli Stati Uniti, accompagnati da una profonda riorganizzazione delle politiche pubbliche, sia a livello nazionale sia comunitario. Nello stesso periodo, la Cina ha raggiunto l’autonomia tecnologica rispetto agli Stati Uniti, modernizzato la propria industria militare, sviluppato un ambizioso programma aerospaziale e consolidato la propria leadership in settori come il digitale, la telefonia, i droni, i satelliti, l’automazione portuale e il settore minerario. Sul piano sociale, il Paese ha ridotto la povertà, redistribuito il reddito e contenuto l’impatto ambientale delle attività economiche.
L’Ue è un ibrido tra federalismo e unione economica
Questa differente reattività al contesto globale tra l’Ue e la Cina trova spiegazione nei limiti strutturali dell’architettura dell’Unione sancita dai trattati. L’Ue soffre di un quadro giuridico ibrido, sospeso tra federalismo e unione economica e monetaria. Questo approccio genera compromessi poco efficaci, decisioni lente e una governance che privilegia la competizione tra Stati invece della cooperazione. Il risultato è spesso inefficienza e, in alcuni casi, paralisi decisionale. In questo contesto emerge un segnale di cambiamento: una proposta di riorganizzazione del bilancio pluriennale e delle modalità di gestione dei fondi europei, attualmente in fase di discussione.
La riforma del Multiannual Financial Framework
Due aspetti tra loro collegati, meritano attenzione per le loro implicazioni potenziali. Il primo aspetto della riforma riguarda la riduzione dei circa 530 programmi nazionali e regionali esistenti in 27 programmi nazionali. Questa trasformazione impatterà profondamente sulla rilevanza delle politiche di coesione economica e sociale nel bilancio comunitario. Tale scelta risponde alla necessità di finanziare altre priorità strategiche come la transizione energetica, la sicurezza e difesa militare, le tecnologie avanzate e l’approvvigionamento di materie prime rare. Il nuovo bilancio prevede un programma nazionale contenente i programmi regionali e locali, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e accelerare la gestione delle risorse. Questo programma sarà al centro del negoziato politico con i Paesi membri della Unione, con l’obiettivo di responsabilizzarli sulla esecuzione e sui risultati. La distribuzione e gestione territoriale delle risorse trasferita agli Stati membri, con modalità ancora da definire, dovrebbero tendere a semplificare e velocizzare l’implementazione degli interventi e generare maggiori sinergie tra fondi europei e bilancio nazionale.
Il potenziale deficit democratico
Tuttavia, è possibile che emerga un potenziale deficit democratico: la minore o comunque indiretta partecipazione di Regioni e Città nelle decisioni strategiche potrebbe compromettere l’efficacia della spesa e generare conflitti istituzionali, oltre che vanificare i benefici politici della partecipazione diretta dei territori. Gli obiettivi della politica di coesione che hanno svolto un ruolo cruciale nell’allargamento a sud e a est dell’Europa rimangono fondamentali per la Unione, dal 2027 dovranno essere “resettate” per rispondere a una pluralità di obiettivi, favorendo sinergie con altri interventi e rapidità di esecuzione laddove il tempo è fattore cruciale di competitività. Il secondo aspetto rilevante del nuovo bilancio è la sua “politicizzazione”. L’Ue intende rafforzare il controllo e la coerenza tra le politiche comunitarie e quelle degli Stati membri attraverso uno scambio tra risorse e riforme. Le riforme diventano una condizione per l’accesso ai fondi, ma anche parte integrante degli obiettivi stessi del bilancio.
Più potere decisionale agli Stati, meno alle regioni
In parallelo, l’Ue trasferisce parte del potere decisionale agli Stati membri, rinunciando al controllo sugli investimenti degli enti territoriali. I pagamenti non saranno più legati al rimborso dei costi, ma alla performance complessiva, includendo riforme e investimenti strategici. Questo approccio richiama l’esperienza del Next Generation Eu, ma solleva interrogativi sulla definizione giuridica e amministrativa delle nuove regole. Il successo di tali cambiamenti dipenderà dal compromesso che si raggiungerà tra istituzioni politiche e organi di controllo. Nonostante le innovazioni proposte, il nuovo bilancio non affronta il tema cruciale del volume di risorse necessarie per contrastare il declino economico e competitivo dell’Ue. La questione di un indebitamento comune rimane sullo sfondo, limitata dai vincoli dei trattati. Questo solleva dubbi sull’adeguatezza delle soluzioni proposte, che, sebbene vadano nella giusta direzione, appaiono incomplete rispetto alle sfide che l’Unione si trova ad affrontare.




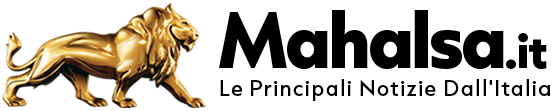

-U51386521188UCY-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?r=1170x507)






