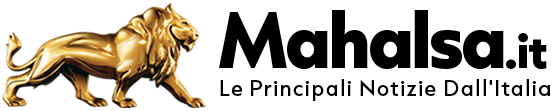Una delle conseguenze dell’invecchiamento della popolazione in Italia e del calo delle nascite è quella che si riduce il divario tra potenziali utenti dei nidi per la prima infanzia e i posti disponibili ma queste soluzioni, sottolinea l’Istat nel Rapporto Bes (Benessere equo e sostenibile) 2024 pubblicato giovedì 13 novembre, non sono per tutti. In Campania, Calabria, Liguria, Puglia, Basilicata e Sicilia meno del 30% dei bambini di 0-2 anni frequentano il nido.
Le asimmetrie a livello territoriale
Nell’anno educativo 2022/2023 sono stati attivi 14.031 servizi per la prima infanzia, con oltre 366 mila posti autorizzati (poco meno della metà a titolarità pubblica). Il divario tra i potenziali utenti e i posti disponibili nei nidi, osserva l’ente statistico, si riduce gradualmente, ma persistono differenze consistenti dal punto di vista territoriale. La frequenza dei bambini tra 0 e 2 anni ricalca la distribuzione delle strutture disponibili sul territorio, caratterizzata da ampie carenze nel Mezzogiorno, a eccezione della Sardegna. Nel triennio 2022-2024, ha frequentato i servizi per l’infanzia il 35,2% dei bambini tra 0 e 2 anni (3,5 punti percentuali in più rispetto al triennio 2021-2023). Più della metà delle regioni ha superato il target europeo del 33% previsto per il 2010; Sardegna ed Emilia-Romagna superano anche il target del 45% previsto per il 2030. In Campania, Calabria, Liguria, Puglia, Basilicata e Sicilia meno del 30% dei bambini di 0-2 anni frequentano il nido.
Il criterio della condizione lavorativa dei genitori
Oltre alle asimmetrie territoriali, le differenze di accesso ai servizi per la prima infanzia sono legate alla loro forte connotazione come strumento di conciliazione vita-lavoro. Il criterio maggiormente utilizzato dai comuni per definire le graduatorie di accesso al nido è la condizione lavorativa dei genitori. I bambini con entrambi i genitori occupati frequentano il nido, infatti, in misura nettamente superiore rispetto ai bambini con nessuno o un solo genitore occupato, monogenitori inclusi (50% contro il 25,8%).
Altre condizioni, come lo svantaggio economico della famiglia, sono considerate per la formazione delle graduatorie solamente da una minoranza di comuni. Sono iscritti al nido il 46,4% dei bambini con genitori laureati, il 33,1% di quelli con genitori con un diploma superiore e il 20% di quelli con genitori con al massimo la licenza media: per i primi il valore è più del doppio degli ultimi. Lo svantaggio economico delle famiglie, la non occupazione di un genitore e la cittadinanza straniera si associano a una minore frequenza del nido. All’età di 4-5 anni, quasi tutti i bambini sono inseriti nei percorsi educativi. Nell’anno scolastico 2023/2024, la quota dei bambini di questa età che hanno frequentato la scuola dell’infanzia o il primo anno di scuola primaria è risalita al 95,0% (era 92,8% nel 2020/2021), con valori più bassi al Centro (92,5%) e più alti al Sud (98%).
Posti negli asili nido in aumento ma non riescono a soddisfare la richiesta
Se si guarda al report sui servizi educativi per l’infanzia in Italia (anno 2023/2024), viene fuori che nell’anno educativo 2022/2023, le unità di offerta censite sul territorio nazionale hanno superato le 14mila unità, con un incremento dei posti complessivi (pubblici e privati) del 4,5% rispetto all’anno educativo precedente. L’incremento di posti realizzato in questi ultimi anni non riesce comunque a soddisfare la domanda di servizi educativi per la prima infanzia, che continua a crescere. Infatti, quasi sei strutture su dieci (59,5%) dichiarano di avere bambini in lista d’attesa, un dato in aumento rispetto al 56,3% rilevato nell’anno precedente. Questo andamento conferma una tendenza all’aumento della domanda da parte delle famiglie, che non trova riscontro in un’espansione sufficiente dell’offerta. Le difficoltà a soddisfare tutte le richieste risultano più marcate nei servizi del settore pubblico: il 68,9% dichiara di avere domande inevase, quota che sale al 73,3% per le unità di offerta pubbliche del Nord. Anche nel settore privato si registrano liste d’attesa, sebbene con minore frequenza: 54% per i servizi privati tout court e 53,7% per quelli convenzionati.